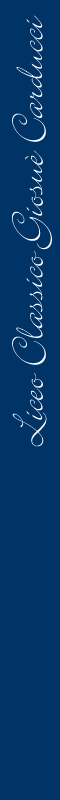In memoriam
Camillo Pedrotti
5 novembre 2006 Cimitero di Lambrate
Caro Camillo, non ci siamo mai scritti lettere, io e te. Tra maschi non si usa, neanche quando un legame di affinità tiene uniti per tutta la vita, e oltre.
Perciò ora faccio fatica a trovare, non le parole, ma il tono. Vorrei lasciarmi andare, ma ci sono tante persone che mi ascoltano e che ti hanno voluto bene. Mi sento un poco a disagio.
La nostra non è mai stata un'amicizia tra adolescenti, ma da adulti, anche se quando ci siamo conosciuti io portavo ancora i pantaloni corti. Ma ero l'unico della classe.
Ti ho preso come modello, per alcune cose. Quando a vent'anni sei passato in Vespa dal campeggio di Cavi con il ferro da stiro nello zaino, mi hai folgorato. Ho capito allora che la libertà passa anche dal sapersi stirare le camicie da soli.
Strana generazione, la nostra, abbiamo preso tutto molto sul serio, sin da ragazzi. Troppo sul serio per fare le cose ci avevano insegnato. Abbiamo cercato di inventarci la vita, ma non ci è riuscito sempre bene.
Noi due abbiamo avuto ciascuno una sola figlia diletta, e altre figlie non nostre ma altrettanto amate. Abbiamo fatto insieme i babbi skilift sulle nevi di improbabili località alpine. Abbiamo tenuto insieme i pezzi della nostre famiglie modulari. Insomma abbiamo fatto del nostro meglio. Per esempio, non abbiamo mai ammazzato le nostre prime mogli, e di questo qualcuno ci renderà merito, anche se a quest'ora, come dicevi tu, saremmo già stati fuori di galera.
Abbiamo lavorato sodo, sempre e a modo nostro, ma non abbiamo messo un soldo da parte. Stiamo ancora pagando il mutuo, però ci possiamo guardare in faccia e nello specchio.
Per anni abbiamo giocato a carte per avere un'occasione di parlare dei nostri problemi, con cinismo e pudore, e quello che mi dicevi non mi arrivava mai scontato. A volte eri tu il fratello maggiore, a volte ero io.
Dieci anni fa, il primo Capodanno a Parigi lo abbiamo passato insieme, come dice Mario, nel mio armadio di rue Tiquettonne, e tu hai camminato per tre giorni nel freddo come non ti ho mai visto fare. Tu che prendevi l'ascensore per scendere un piano di scale.
Con Paola ti abbiamo trovato per terra l'altra sera, circondato da quattro o cinque energumeni che te le davano sodo. Volevo intervenire in tua difesa, come ai bei tempi, ma non erano fascisti. Erano brave persone vestite di arancione che non volevano rassegnarsi a capire che eri già morto. Sul tavolo c'era il leggio con un libro ancora aperto, da un lato la trinitrina, dall'altro il sigaro acceso. Ci siamo dati a vicenda delle teste di cazzo una infinità di volte, e non voglio ripetermi. Ma questa volta ho l'impressione che tu l'abbia fatto apposta.
Giulia dice che te ne sei andato in un modo che corrisponde molto alla tua particolare sensibilità, molto più della discrezione: senza disturbare nessuno, quando ti sei sentito tranquillo che tutto fosse a posto, di venerdì sera, con davanti il week end per sistemare tutto. Non so se è vero...
Però quando ti abbiamo steso sul letto, nella tua stanza della nuova casa che mi avevi fatto vedere con soddisfazione quasi infantile, avevi un volto disteso e sereno, come da tempo ormai ti vedevo di rado. Non sembrava che avessi appena finito di essere pestato per più di mezz'ora. Solo i capelli un po' scarruffati sulla tempia sinistra, come ti capitava spesso negli ultimi tempi.
Sul comodino c'era una pila di libri, metà di fantascienza, vecchi Urania, e metà di scienza. Non hai mai smesso di essere curioso, soprattutto delle idee e delle grandi teorie. Ricordo quella volta che io, passando in tua assenza a ritirare la posta dalla casa di via Calvino di cui condividevamo le chiavi, ho visto sul tavolo che stavi leggendo un libro di fisica e ti stavi appuntando uno schema delle forze fondamentali. Allora ti ho lasciato un biglietto per dirti che l'elettromagnetica e la debole erano state da poco unificate in un'unica forza, e sapevo che quello era un codice che non avrei potuto condividere con altri.
Uno degli infermieri che ti avevano menato, a fin di bene, mi ha chiesto che cosa erano le croste che avevi sulle braccia. Non te l'ho mai chiesto, è sempre rimasto un tabù tra di noi. Gli ho risposto che ti grattavi involontariamente per nervosismo. Poi sono andato in bagno e ho fatto pipì nell'orinatoio di cui eri tanto orgoglioso. Tu e Gino mi avevate promesso che sareste venuti a pisciare sulla mia tomba, ricordi? Questa non l'hai mantenuta.
Mi sento molto più solo oggi, però venendo via dalla tua casa, l'altra sera, ho finalmente trovato anche le lacrime che non ero riuscito a piangere alla morte di mio padre, quando avevo 19 anni. E poi a quelle di Raffaele e del Popi.
Mi resta molto di te, sparso un po' da tutte le parti. Per esempio i tuoi modi di dire, che per tutta la vita ho assorbito e ripetuto senza neppure sapere da dove venissero, ma che mi sembrano così evidenti. Quest'estate in Cina, con tanti amici, mi è venuto fuori quello dei "pezzi di vigile", e ho fatto una gran fatica a cercare di spiegarlo agli altri. Né penso di riuscirci adesso. Altro che lessico familiare: "El gha dito cuiaton!".
Ti ho invidiato anche, vedendoti così lontano, sereno e irraggiungibile, su quel letto. Ma mi vergogno a dirlo, e perciò la chiudo qui questa lettera, Cami, e ti saluto.
Roberto Satolli
Scarica il filmato, spezzone di una partita di calcio del 1966 tra II E e II B in cui si vedono Camillo Pedrotti e Roberto Satolli in porta (764 KB, formato Windows Media Video)
Foto di Camillo Pedrotti
Leggi l'articolo in terza pagina di Camillo Pedrotti dal giornalino studentesco "Mr Giosuè" (1,3 MB, formato PDF)
|
|